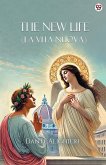Questa trilogia si colloca fra le opere più tarde, quelle in cui Pirandello svolge, in modi imprevedibili, la sua personale mitologia della "rinascita". Lontani ormai dal meccanismo teatrale dei "Se personaggi", dal continuo scambio fra realtà e finzione del "teatro nel teatro", questi miti (come Pirandello stesso li chiama) si pongono come forme di teatro epico-collettivo: i tre piani simbolici della fede (Lazzaro), dell'utopia sociale (La nuova colonia) e dell'arte (l'incompiuto I giganti della montagna) esprimono un'unica volontà di far uscire il dramma dal circuito individuale del personaggio e di strappare all'azione scenica, attraverso la catarsi nell'immaginario e nel simbolismo universale, messaggi di valore generale e conclusivo.
Dai capolavori drammatici alle commedie grottesche e borghesi, la visione di un mondo dominato dall'inautenticità e dal continuo scambio tra realtà e finzione è la cifra del teatro di Pirandello. Con la trilogia qui raccolta, che conclude la sua parabola artistica e ideologica, l'autore abbandona le sofisticate invenzioni del «teatro nel teatro» per cercare la catarsi nel simbolismo del mito. Gli apologhi dell'utopia sociale (La nuova colonia, 1928), della fede (Lazzaro, 1929), dell'arte (nell'incompiuto I giganti della montagna , 1937) esprimono la volontà di far uscire il dramma dalla dimensione individuale per farne il veicolo di un messaggio profetico e universale. Serpeggia in questi testi un'ansia di rinnovamento ideale, segno dell'inesausta vitalità di un drammaturgo che, dopo aver contribuito a rivoluzionare la scena teatrale del primo Novecento, si interroga in tempo di dittature e presagi di guerra sulla responsabilità sociale e morale dell'arte. Introduzione di Nino Borsellino. Prefazione e note di Marziano Guglielminetti.
Dai capolavori drammatici alle commedie grottesche e borghesi, la visione di un mondo dominato dall'inautenticità e dal continuo scambio tra realtà e finzione è la cifra del teatro di Pirandello. Con la trilogia qui raccolta, che conclude la sua parabola artistica e ideologica, l'autore abbandona le sofisticate invenzioni del «teatro nel teatro» per cercare la catarsi nel simbolismo del mito. Gli apologhi dell'utopia sociale (La nuova colonia, 1928), della fede (Lazzaro, 1929), dell'arte (nell'incompiuto I giganti della montagna , 1937) esprimono la volontà di far uscire il dramma dalla dimensione individuale per farne il veicolo di un messaggio profetico e universale. Serpeggia in questi testi un'ansia di rinnovamento ideale, segno dell'inesausta vitalità di un drammaturgo che, dopo aver contribuito a rivoluzionare la scena teatrale del primo Novecento, si interroga in tempo di dittature e presagi di guerra sulla responsabilità sociale e morale dell'arte. Introduzione di Nino Borsellino. Prefazione e note di Marziano Guglielminetti.